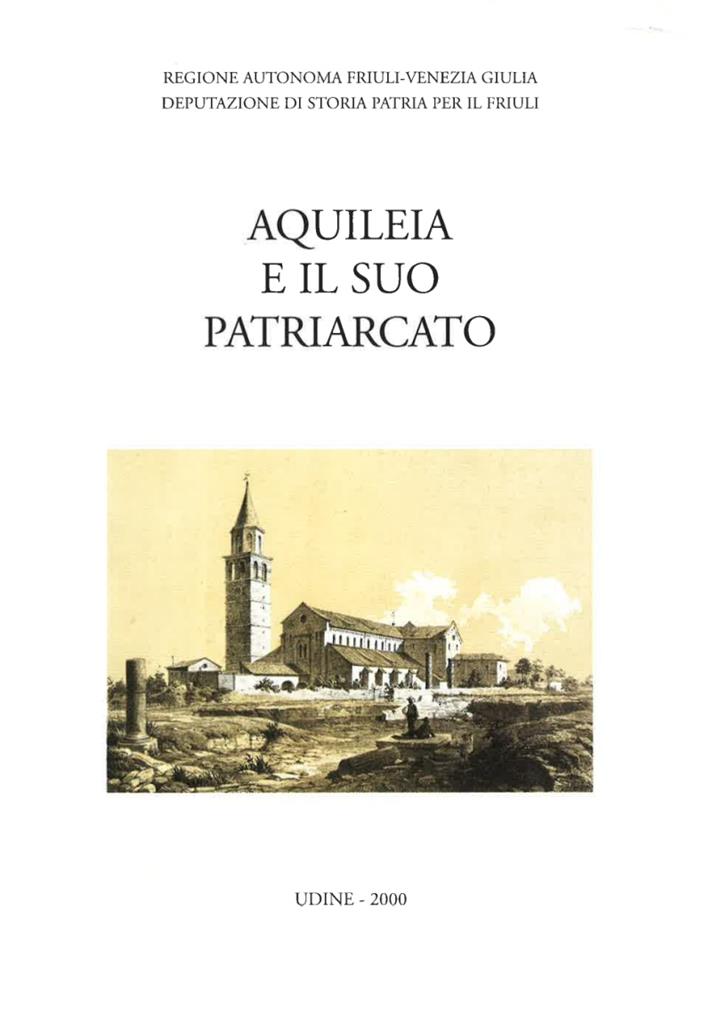
Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria del FriuliAquileia e il suo Patriarcato, Atti del Convegno Internazionale di Studio (Udine, 21-23 ottobre 1999)
a cura di Sergio Tavano, Giuseppe Bergamini, Silvano Cavazza
Udine, 2000
Collana delle Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria per il Friuli, nr. 29
Il Convegno, di cui qui sono pubblicati gli atti, segue quello tenuto ad Aquileia nel 1999 sulle “Antichità altoadriatiche” che indagava il passaggio della città dalla romanità al cristianesimo. Entrambi accompagnano idealmente le mostre di Aquileia e Cividale sui patriarchi (Patriarchi: quindici secoli di civiltà fra l’Adriatico e l’Europa orientale). Questo secondo convegno, tenutosi a Udine dal 21 al 23 ottobre 1999, affronta invece la storia del patriarcato di Aquileia (e quindi della Chiesa aquileiese) dall’età dei martiri alla soppressione, nel 1751.
Il volume ospita moltissimi interventi di studiosi italiani e internazionali, volti a far conoscere la storia di questa istituzione così peculiare sia nel momento del potere temporale, sia, soprattutto, lungo i secoli di una estesa giurisdizione ecclesiastica. Così si indagano il titolo stesso di patriarca, collegato alla tradizione della derivazione marciana (e più avanti, un altro saggio si occupa della rappresentazione che gli stessi patriarchi fecero si se stessi, ad esempio nei sigilli); i protomartiri della chiesa aquileiese e delle loro reliquie; la storia delle tre fasi del primo complesso basilicale studiata attraverso i mosaici e relative al periodo che va dal vescovo Teodoro (IV secolo) alla distruzione ostrogota (metà V secolo). Vengono poi studiate altre figure di rilievo per la storia aquileiese, come Colombano e Cromazio, si indagano i rapporti con i barbari nei primi secoli della Aquileia cristiana (soprattutto Ostrogoti, Unni, Longobardi), la presenza di monasteri pre-longobardi, e di forme di ascetismo (anche femminili). Vengono studiati, sulla base dei manoscritti liturgici, le vicinanze e le difformità tra rito patriarchino aquileiese e quello della chiesa di Como. Si indaga l’organizzazione delle pievi slovene (soprattutto della Carniola) nella seconda metà del X secolo; si affrontano anche le questioni numismatiche: la circolazione monetaria con conio veneziano e la diffusione temporanea del frisiacennse (poi denominato aquileiese), a scapito del denaro veneziano. Viene tracciata la storia anche genealogica dei molti patriarchi del basso medioevo, quasi tutti bavaresi, franchi o svevi. Risalendo la storia incontriamo Ottocaro II Přemyzl di Boemia, che a metà del XIII secolo diventa vassallo del patriarca Gregorio da Montelongo e per breve tempo “signore” di Pordenone (per perdere poi sotto Raimondo della Torre e soprattutto con l’avvento di Rodolfo d’Asburgo ogni territorio in Austria e ogni pretesa sul Friuli). Si studia il seguito patriarcale (da Pellegrino I a Bertoldo) fatto di abati, prepositi e laici e, con alcuni patriarchi, soprattutto di loro parenti. Un capitolo interessante riguarda i rapporti tra il patriarcato e i conti di Gorizia, che dal 1125 esercitarono sulla chiesa aquileiese i diritti di awocazia avuti in feudo dai conti di Peilstein. Si studia la storia dell’abbazia di Rosazzo, fondata da Marquardo II di Eppenstein. I patriarchi furono anche margravi della Carniola (formatasi tra X e XI secolo) a partire dal 1077 con Sigeardo e, dopo la morte di costui, con Ulrico di Eppenstein e i suoi successori – che esercitarono il potere su questa zona concedendola in feudo ereditario ai loro luogotenenti – fino alla fine del XIII secolo, quando con l’avvento degli Asburgo i patriarchi vi persero ogni potestà. A metà Quattrocento, quando termina il potere temporale del patriarca con l’avvento della Serenissima repubblica di Venezia, risale la fondazione della diocesi di Lubiana, che secondo l’imperatore Federico III avrebbe dovuto in qualche modo “limitare” quella aquileiese pur essendo a lei sottomessa (ma l’imperatore avocava a sé le nomine dei vescovi, da quel momento sempre sudditi asburgici). Segue uno studio sulle pievi friulane, dal XIII secolo, nate sulla base di antiche chiese dotate di fonte battesimale e rette da ecclesiastici di vario ruolo: dai pievani (e dai loro vicari) ai religiosi residenti nelle vicinanze (cappellani, titolari e vicari) con una articolazione abbastanza complessa. La lingua usata nel patriarcato probabilmente era una varietà latina, che a causa dell’isolamento culturale e della presenza di patriarchi di area tedesca, risente di questa influenza almeno fino a metà del Duecento quando, con il primo patriarca italiano Gregorio di Montelongo, il Friuli inizierà ad avvicinarsi anche linguisticamente all’area veneta. Nel corso del Cinquecento il fenomeno della Riforma protestante e della Controriforma interessa naturalmente anche i territori di competenza ecclesiale del patriarcato: ma i patriarchi Grimani non brillano per rigida osservanza, non risiedendo neppure in Friuli e finendo sotto la lente dell’Inquisizione. Il riavvicinamento a Roma e ai decreti tridentini sarà compiuto – qualche tempo dopo - dal patriarca Francesco Barbaro. All’inizio dell’Età moderna anche la politica imperiale asburgica nel suo “confronto” con Venezia, determina l’offuscamento e la decadenza del patriarcato. Venezia fin da subito teme che l’Austria tenti di reintegrare Aquileia (e di conseguenza il Friuli) nell’impero. Vienna tenta di dimostrare che la Serenissima si è indebitamente appropriata del patriarcato togliendo all’impero il dominio temporale su di esso (con la nomina dei patriarchi). Così l’idea della suddivisione tra i territori di competenza asburgica e veneziana si può dire inizi ben prima della soppressione del Patriarcato che avverrà sotto Maria Teresa nel 1751. L’epoca degli ultimi patriarchi è studiata anche nelle opere di abbellimento del palazzo udinese da parte del Tiepolo. Chiudono la rassegna uno studio sul recupero del polittico di Pellegrino da San Daniele ad Aquileia e sugli interventi di restauro degli archivi capitolari di Aquileia (ciò che ne resta) e di Udine.
Indice: Premessa; Sergio Tavano, Patriarchi: titoli e segni; Giuseppe Cuscito, I martiri aquileiesi; Franz Glaser, Fosse per le reliquie; Luisa Bertacchi, Le fasi architettoniche del complesso episcopale di Aquileia nelle variazioni dei mosaici; Pier Franco Beatrice, Hermagorica novitas: la testimonianza di Colombano sullo scisma dei Tre Capitoli; Joseph Lemarié, La tradition textuelle de l’oeuvre de Chromace d’Aquilée; Rajko Bratož, La chiesa aquileiese e i barbari (V-VII sec.); Massimo Dissaderi, Sul monachesimo ‘prebenedettino’ aquileiese (IV-VII secolo); Angelo Rusconi, Il rito e il canto patriarchino nelle aree periferiche: fonti e bibliografia, “status quaestionis”, prospettive di ricerca; Janez Höfler, Le pievi delle origini e la prima organizzazione ecclesiastica nel territorio sloveno del patriarcato di Aquileia; Andrea Saccocci, I presupposti della monetazione patriarcale di Aquileia (secc. VI-XII); Ingeborg Baumgartner, Fonti scritte per la numismatica patriarcale; Reinhard Härtel, L’autorappresentazione dei patriarchi; Heinz Dopsch, Origine e posizione sociale dei patriarchi di Aquileia nel tardo medioevo; Josef Riedmann, II re Ottocaro di Boemia "dominus Portus Naonis et defensor ecclesie Aquilegensis et terre Foriiulii"; Günther Bernhard, La nobiltà al servizio dei patriarchi; Marija Wakounig, 'Avvocato" contro signore. Il ruolo dei conti di Gorizia nel patriarcato d'Aquileia; Wilhelm Baum, Die Geschichte der Abtei Rosazzo im Mittelalter; Peter Štih, I patriarchi di Aquileia come margravi della Carniola; France M. Dolinar, L’istituzione della diocesi di Lubiana; Flavia De Vitt, Pievi e parrocchie nel Basso Medioevo friulano; Giovanni Frau, Aspetti linguistico-culturali nelle terre patriarcali; Giovanna Paolin, L’applicazione del Concilio di Trento nel patriarcato; Giuseppe Trebbi, Il patriarca di Aquileia Francesco Barbaro e il Concilio di Trento; Karl Heinz Frankl, L’impero e il patriarcato di Aquileia nell'età moderna; Giuseppe Bergamini, Committenze patriarcali nell’età del barocco; Fabio Metz, Lorenzo Nassimbeni, Documenti musicali nella terra patriarcale di San Daniele del Friuli; Friedrich Edelmayer, La Casa d'Austria e la fine del patriarcato di Aquileia: argomenti e polemiche; Massimo Bonelli, Maria Romana Rizzi, Un recupero complesso: il polittico di Pellegrino di San Daniele della basilica di Aquileia; Renata Da Nova, Fondi archivistici riguardanti il patriarcato di Aquileia.
Aprendo la scheda bibliografica è possibile consultare i contributi del volume in formato digitale.