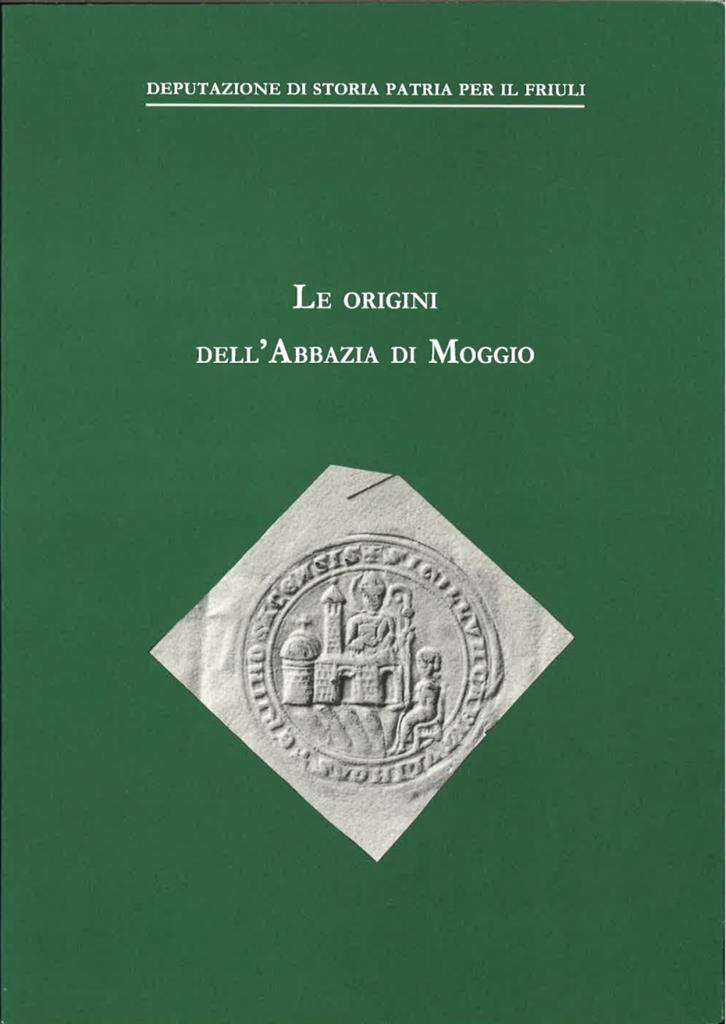
Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria del FriuliLe origini dell’Abbazia di Moggio e i suoi rapporti con l’Abbazia svizzera di San Gallo, Atti del convegno internazionale (Moggio, 5 dicembre 1992)
Udine, 1994
Collana delle Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria per il Friuli, nr. 21.
Tracciare le origini e la storia antica dell’abbazia di Moggio è l’intento principale del convegno internazionale tenutosi a Moggio nel 1992. Si parte da un’antica e per secoli ripetuta leggenda secondo cui tal Cacellino, conte palatino, prima di affrontare un lungo viaggio in Terra Santa, decise di fare testamento donando molti possedimenti al patriarca Federico suo parente e chiedendo che, ove sorgeva il castello di Moggio, fosse fondato un monastero benedettino in onore della Madonna e di San Gallo. Vi provvide il successore di Federico, Ulrico (o Udalrico) di Eppenstein, di nobile famiglia stiriana, abate di San Gallo, eletto patriarca di Aquileia nel 1086. La figura di Cacellino è storica (proveniva da una famiglia germanica ed era già al seguito di Sigeardo come poi dei suoi successori Federico e Ulrico), così come è certa la donazione dei suoi beni al patriarcato per la fondazione di una chiesa a Ebendorf in Germania. Certa va considerata anche la fondazione del monastero di Moggio con il concorso di Ulrico di Eppenstein, che consacrò il monastero nel 1119 (introdusse la regola benedettina anche a Rosazzo). Tuttavia non è esatto affermare, come narrato da una tradizione probabilmente confezionata dagli stessi monaci, che l’abbazia fosse una filiazione di San Gallo: il monastero benedettino di Moggio poggia su una crescente stratificazione liturgica con una forte componente tedesca che deriva da Hirsau (antica Hirschau, abbazia benedettina tedesca fra le più importanti) ed è confermata dalla venerazione di santi tedeschi, dall’uso della liturgia di Hirsau, dalla lingua tedesca dei monaci, e dalla stessa fattura tedesca dei codici miniati che attesta anche la provenienza dei primi monaci. C’è senz’altro una componente sangallense negli strati più antichi (per la venerazione di santi da lì provenienti) e naturalmente una componente aquileiese, ma almeno al momento della fondazione prevalgono i legami con la Germania. L’abbazia di Moggio, che dalla fondazione a tutto il Medioevo rimase centro spirituale e punto di riferimento per la popolazione della Val Canale e della Carnia (l’abbazia aveva giurisdizione su un vasto territorio che raggiungeva Dignano), vide un progressivo declino dal Quattrocento, quando da regolare venne affidata in commenda ad abati non più residenti (uno di essi fu San Carlo Borromeo), e dopo episodi di spoliazioni e devastazioni venne soppressa dalla Serenissma nel 1773, per essere nuovamente ripristinata (dietro le forti insistenze della popolazione) nel 1869 con l’attribuzione del titolo di abate all’arciprete di Moggio.
Indice: Gian Carlo Menis, Presentazione. L’origine dell’Abbazia di Moggio; Reinhard Härtel, Le fonti diplomatiche e la fondazione dell’Abbazia di Moggio; Werner Vogler, Ulrico di Eppenstein e l’Abbazia di San Gallo di Moggio; Peter Ochsenbein, Tracce della liturgia san gallese nei codici moggesi di Oxford e Udine; Walter Berschin, La “Vita S. Galli”; Giusepe Bergamini, Codici miniati dell’Abbazia di Moggio; Cesare Scalon, Moggio nella circolazione libraria del Friuli patriarcale; Flavia De Vitt, Il Fondo “Moggio” dell’archivio arcivescovile di Udine; Paolo Goi, Contributo all’iconografia di S. Gallo in Friuli; Novella Cantarutti, Spunti nella tradizione maggese intorno a San Gallo; Vinicio Tomadini, Testimonianze archeologiche dalla torre dell’Abbazia di Moggio; Bruno Lucci e Mirt Faleschini, La “Strade dai fraris”: ipotesi di una antica strada.
Aprendo la scheda bibliografica è possibile consultare i contributi del volume in formato digitale.