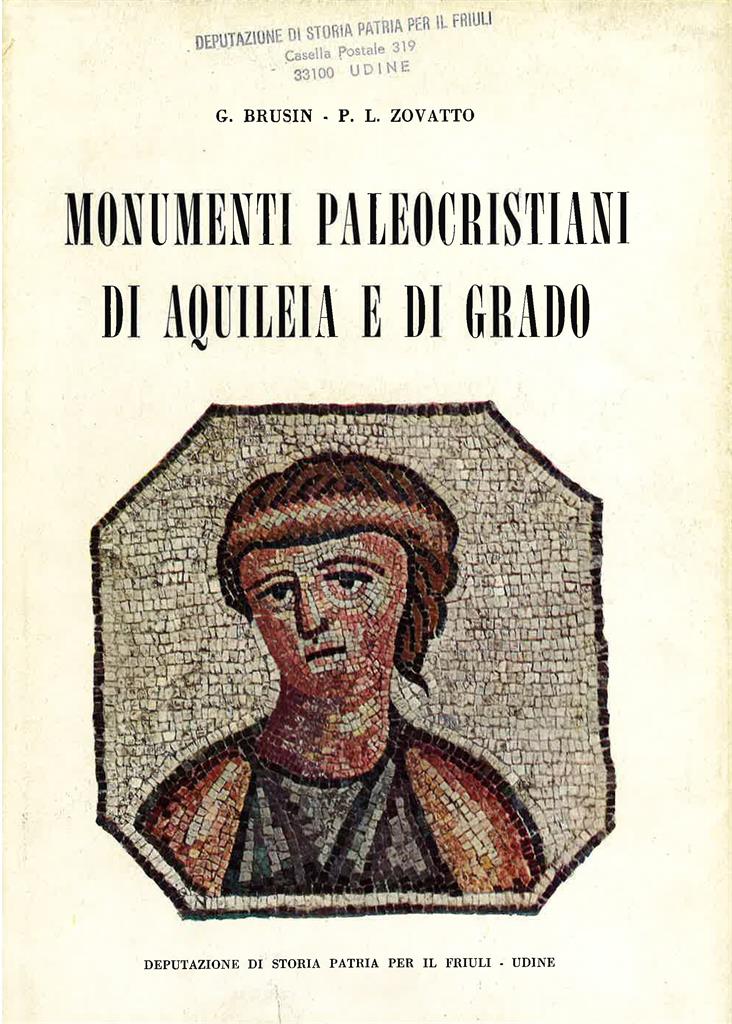
Monumenti paleocristiani di Aquileia e Grado
Giovanni Battista Brusin, Paolo Lino Zovatto
Udine, 1957
Nata in collaborazione tra la Deputazione di storia patria per il Friuli e la Banca del Friuli che ne onora il direttore Luigi Bon di fatto finanziandola, l’opera si aggancia idealmente al primo volume sui monumenti del Friuli del Cecchelli, edito nel 1943, cui avrebbe dovuto far seguito un secondo volume appunto incentrato su Aquileia e Grado, che però non vide mai la luce. Giovanni Brusin, archeologo e presidente della Deputazione e don Paolo Lino Zovatto docente all’università di Trieste, si propongono di indagare sotto il profilo storico, archeologico e artistico le due località così significative per il Friuli: Aquileia, di cui si studia la basilica primitiva (oggetto di un corposo volume nell’occasione del nono centenario della ricostruzione popponiana), ma anche altri monumenti posti a non molta distanza, della Beligna e di Monastero; e Grado, che, riflettendo schemi tipologici aquileiesi, diventa modello di edilizia e arte cristiana. Nella prima parte del volume, corredato di moltissime fotografie anche a colori, viene quindi presentata la basilica di Santa Maria Assunta, sorta nel IV secolo sotto il vescovo Teodoro, ampliata successivamente verso nord, con i pavimenti musivi descritti nel dettaglio. A questo ampliamento post-teodoriano ne segue uno successivo all’invasione unna, che amplia la parte sud, cui è annesso il battistero dell’epoca. Segue poi lo studio di alcuni oratori, tutti con tappeto musivo, in località non distanti dalla Basilica: quelli di alcuni fondi agricoli. Si ripropone uno studio del Brusin arricchito dalle note dell’architetto De Grassi relativo all’aula cultuale rinvenuta alla Beligna, che poi aveva subito l’usuale trasformazione in basilica absidata. Viene riproposto anche uno studio relativo a un monastero, che ha poi dato origine all’omonima località, forse inizialmente di benedettini e poi di monache, dedicato a Santa Maria “extra muros Aquileiae” (erette da Poppone nell’XI secolo) e soppresso da Giuseppe II nel 1782. Se i pavimenti musivi occupano la gran parte dell’analisi artistica del volume, non possono essere dimenticate alcune sculture di particolare interesse: bassorilievi (come quello di Pietro e Paolo) e incisioni su pietra.
La seconda parte della pubblicazione, curata da don Paolo Livio Zovatto, è dedicata allo studio delle basiliche di Grado: in epoca romana era il porto con scalo per le merci all’imboccatura del fiume, risalendo il quale si giungeva ad Aquileia. Nel IV secolo Grado vive ancora nell’area di influenza aquileiese, e a fine secolo è datata la prima chiesa, sottostante la basilica di S. Eufemia (rinnovata da Elia a fine VI secolo), e probabilmente anche il battistero. All’inizio del V secolo si possono datare sia la basilica di Santa Maria che quella della piazza Vittoria, sorte durante il periodo delle invasioni barbariche. Con l’arrivo dei Longobardi la sede patriarcale era spostata a Grado, mentre ad Aquileia veniva eletto un patriarca scismatico col favore dei nuovi padroni. Non poteva mancare infine l’analisi delle capselle o reliquiari conservati nel Tesoro del Duomo di Grado e di una cattedra detta di San Marco, in alabastro, conservata a Venezia, adibita a reliquiario e databile tra fine VI e inizi VII secolo, forse eseguita in Oriente: donata al patriarca Primigenio nel 630 dall’imperatore bizantino, con la soppressione della sede patriarcale di Grado avvenuta nel 1451, la cattedra fu poi portata a Venezia.
Sommario della materia: Monumenti paleocristiani di Aquileia (Giovanni Brusin) e di Grado (Paolo Lino Zovatto); Premessa (Egidio Zoratti); Introduzione (Giovanni Brusin). I. Il complesso degli edifici cultuali nella zona della basilica di Aquileia: cenni sugli scavi. 1. L’aula cultuale nord trasformata poi in chiesa; 2. L’aula cultuale sud del vescovo Teodoro; 3. La zona intermedia tra le due aule; 4. La basilica postteodoriana; 5. La basilica postattilana. II. Gli oratori. 1. L’oratorio del fondo fratelli Cossar; 2.L’oratorio del fondo della Cal lungo la via Giulia Augusta; 3. Resto di oratorio del fondo di proprietà comunale lungo la via Giulia Augusta. III. La basilica del fondo Tullio alla Beligna di Aquileia. 1. Scavo e descrizione della basilica con cenni sulla Beligna; 2. Misure – Architettura della basilica; 3. Il presbiterio della basilica e il suo mosaico; 4. Qualche osservazione sulla vite e sullo stile del mosaico; 5. I mosaici del transetto e dell’oblongum; 6. Brevi osservazioni di carattere tecnico; 7. Probabile data della basilica; 8. L’architettura della basilica (Virgilio De Grassi). IV. La chiesa di Monastero. 1. Cenni sul nome di Monastero; 2. Il piccolo scavo del 1895; 3. L’esplorazione del 1949 e 1950; 4. Descrizione del mosaico; 5. Le epigrafi degli offerenti del pavimento musivo. V. Probabili o presunti edifici cultuali paleocristiani. 1. Pavimenti musivi figurati; 2. La trichora. VI. Monumenti di scultura di singolare interesse. 1. Ss. Pietro e Paolo; 2. Il titulus con la scena del battesimo; 3. Il marmo con la vite e i pesci. Addenda et corrigenda. Monumenti paleocristiani di Grado. Introduzione (Paolo Lino Zovatto). I. Il battistero di Grado. II. La basilica di Santa Maria. III. La basilica di Sant’Eufemia. IV. La basilica di piazza Vittoria. V. La capsella argentea di Grado con le immagini clipaetae. VI. La capsella con l’immagine di Maria Regina. VII. La cattedra-reliquiario del Tesoro di S. Marco a Venezia. Indici: Indici dei nomi e dei luoghi di persone; Indici dei nomi delle epigrafi; Indici delle illustrazioni dei monumenti paleocristiani di Aquileia; Indici dei monumenti paleocristiani di Grado; Indice delle piante; Indice delle tavole; Sommario della materia.
Aprendo la scheda bibliografica è possibile consultare i contributi del volume in formato digitale.