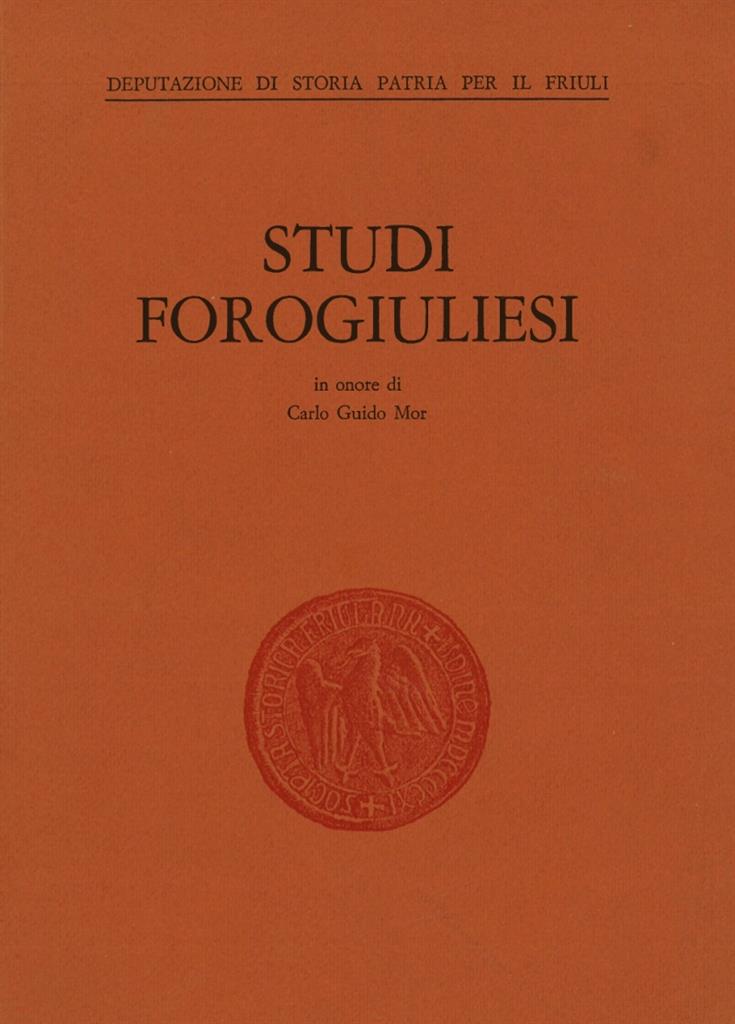
Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria del FriuliStudi Forogiuliesi in onore di Carlo Guido Mor
a cura di Giuseppe Fornasir
Udine, 1983
Collana delle Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria per il Friuli, nr. 13.
Nel 1983 la Deputazone di Storia patria per il Friuli, diretta da Carlo Guido Mor, dedica al suo presidente questa raccolta di saggi. L’intitolazione rende omaggio alla sua città di adozione, Cividale, e ai molti suoi scritti pubblicati sulle Memorie storiche forogiuliesi. Alla presentazione del vicepresidente Gian Carlo Menis, segue la corposa bibliografia curata da Giuseppe Fornasir. I contributi si occupano di svariati argomenti che toccano molti centri del Friuli e la sua storia. Si parte dai lasciti celti (anche mediati dal latino) nella toponomastica friulana, si esplorano le vestigia tardo-romane di strade e monumenti, si indaga la cristianizzazione del Friuli attraverso la dislocazione degli edifici di culto, ma anche attraverso figure come San Cromazio e Rufino. L’epoca longobarda vede una penetrazione nei territori di tradizione bizantina tra Padova, Rovigo e Chioggia testimoniata dai ritrovamenti archeologici. Questi sono anche alla base del rinvenimento del bacile bronzeo di fattura germanica (secolo XI) rinvenuto lungo il fiume Stella. Al XII secolo risale una decisione di Vodolrico II d estendere le consuetudini abbaziali ai canonici aquileiesi. Sul fronte dell’arte si studia il Grassi presente a Buia con tre dipinti che potrebbero essere elementi di un trittico, si esaminano alcuni dipinti inediti del Fontebasso, i manoscritti di Leopoldo Zuccolo sui pittori friulani e i monumenti settecenteschi dei Manin in Duomo a Udine, opera di artisti come Torretti, Corradini e Baratta. In Friuli ci sono nuclei importanti di Ebrei, come quelli presenti a San Vito al Tagliamento, per lo più banchieri e prestatori, che godono di qualche privilegio dovuto alla giurisdizione patriarcale, ma che nel XVII secolo vengono costretti a spostare le abitazioni lontano dal centro città. Della vita pubblica in Terraferma parlano le relazioni presentate al Senato Veneto da provveditori e luogotenenti tra 1524 e 1797: l’interesse principale della Serenissima è la visione chiara e organica della situazione sociale, politica, economica e militare delle terre soggette al suo dominio. Di ambito veneziano è anche la vicenda dell’incendio dell’Arsenale, nel 1569, secondo la relazione del futuro doge Leonardo Donà. Di interesse più contemporaneo sono il saggio sull’attività di commissario di Quintino Sella all’indomani dell’annessione del Friuli al Regno d’Italia (1866) e la storia delle spoglie dello storico Francesco di Manzano. Chiudono la pubblicazione alcuni saggi di linguistica relativa alla lingua friulana, studiata nei nomi degli astri, a proposito del termine “orma” e nei friulanismi e slavismi del dialetto triestino.
Indice: Gian Carlo Menis, Presentazione; Giuseppe Fornasir, Bibliografia; Cornelio Cesare Desinan, A proposito di Celti nella toponomastica friulana; Luciano Bosio, Mutatio Apicilia; Sandro Stucchi, Possibili rapporti metrici nel Mausoleo di Aquileia; Sergio Tavano, Orientamenti urbanistici e culturali nella cristianizzazione di Aquileia; Joseph Lemarié, La diffusion des oeuvres de Saint Chromace d’Aquilée dans les Scriptoria d’Italie; Giulio Trettel, I due interventi di Cromazio al Concilio di Aquileia del 381; Antonio Carlini, Le sentenze di Sesto nella versone di Rufino; Mario Brozzi, Sull’occupazione longobarda della Venezia marittima; Cesare Scalon, Un documento aquileiese inedito del 1183; Giovanni Maria Del Basso, De consolazione philosophieae di Severino Boezio; Carlo Gabersceck, Il bacile con le storie di Sansone nel museo civico di Udine; Giovanni Comelli, Francesco da Udine tipografo a Udine del primo Cinquecento; Gian Carlo Menis, Contributo a Gian Battsta Grassi; Federico Seneca, L’incendio dell’Arsenale di Venezia (1569); Amelio Tagliaferri, Rettori veneti e governo della cosa pubblica in terraferma; Aldo Rizzi, Due inediti del Fontebasso; Pier Cesare Ioly Zorattini, L’università degli ebrei di San Vito al Tagliamento; Paolo Goi, Torretti e gli altri nei mausolei Manin di Udine; Giuseppe e Antonietta Bergamini, Leopoldo Zuccolo e i suoi manoscritti sui pittori friulani; Tito e Giovanni Miotti, Quintino Sella regio commissario in Friuli; Giuseppe Fornasir, La chiesetta di Giastico custodisce i resti mortali dello storico friulano Francesco di Manzano; Giovanni Frau, Le denominazioni friulane degli astri; Giovanni Battista Pellegrini, Noterelle di onomasiologia friulana; Mario Doria, Sugli slavismi de dialetto triestino giunti per intermediazione friulana.
Aprendo la scheda bibliografica è possibile consultare i contributi del volume in formato digitale.