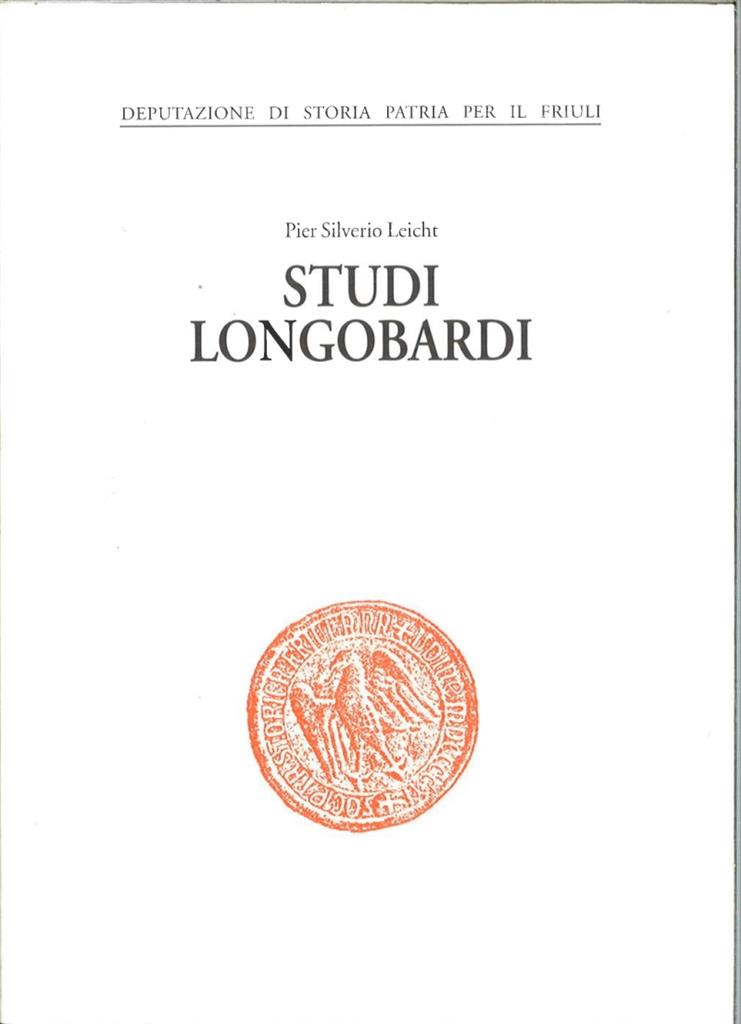
Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria del FriuliStudi Longobardi
Pier Silverio Leicht
Udine, 1996
Collana delle Pubblicazioni della Deputazione di Storia Patria per il Friuli, nr. 24
La pubblicazione, pensata dalla Deputazione per il quarantesimo anniversario dalla morte di Pier Silverio Leicht e sostenuta dal nipote di questi, Gherardo Sassoli de Bianchi, riunisce studi sul diritto longobardo pubblicati in varie epoche e in edizioni di difficile accesso. Leicht indaga le fattispecie giuridiche di epoca longobarda (talvolta mutuate dal diritto romano) che permangono anche con Carlo Magno e fino al Basso Medioevo. Si tratta di figure giuridiche presenti durante l’epoca longobarda, ma che certamente riguardano anche l’epoca carolingia, talora fino a tutto il Medioevo: l’arimannia, terra (poi pascolo), ma anche tributo dovuto da uomini liberi (gli arimanni) al feudatario (o alla Chiesa); il “mediatore” a garanzia di un debito (attraverso una cauzione), già presente in epoca romana; il corteo nuziale dei “troctingi” (uomini della famiglia, armati) che garantisce il passaggio della sposa da un gruppo familiare ad un altro “in sicurezza” e una formula lombardo-toscana di morgengabe, ovvero la donazione fatta alla sposa dallo sposo di una parte dei suoi averi; forme di vassallaggio (in area longobarda e germanica si parla di gasindato); e infine le ultime ordalie e i duelli giudiziari, rispondenti all’obbligo di vendetta” (nel caso di un ereditando ucciso), istituti che i Longobardi ritenevano già superati ai tempi di Liutprando, ma che erano poi state mantenute dagli Ottoni in avanti, con il favore di una popolazione diffidente verso le lunghe disquisizioni giuridiche della tradizione romana. I Longobardi invadono l’Italia e si affiancano a una popolazione che si percepisce “romana”, ma che di fatto deve sottostare al nuovo potere: lo testimoniano anche fatti marginali come un capitolo dell’editto di Rotari che punisce maggiormente la violenza compiuta sulla serva di origine germanica, rispetto allo stesso crimine condotto sulla serva di origine romana. Il problema in realtà non riguarda l’origine delle serve, ma quella dei loro padroni. Germanici e “ladini” sono elencati separatamente in un giuramento lucchese dell’825, e questo mostra come taluni uomini liberi, vassalli del re chiaramente di origine romana, avessero potuto mantenere i propri possedimenti lungo tutta l’epoca di dominazione longobarda. Con Ludovico il Pio e soprattutto con il figlio di lui Lotario, i re franchi “perdono” l’appellativo di “rex Francorum et Langobardorum” per adottare quello di “rex Italiae”, mentre dall’817 (anno di ascesa al trono di Lotario) si parlerà di “Regnum Italiae”: l’autore ipotizza la volontà da parte del nuovo potere franco di cancellare il ricordo della supremazia esercitata, per due secoli, dal Longobardi nel territorio italiano.
Indice: Gian Carlo Menis, Presentazione; Gherardo Sassoli de Bianchi, Dedica. Ricerche sull’arimannia; I mediatores de vadimonio; Troctingi e paraninfi nel matrimonio longobardo; La formula del morgengabe nel formulario lombardo-tosco; Romani e Germani in un giuramento carolingio; La “romana ancilla” del capitolo CXCIV dell’editto di Rotari; Gasindi e vassalli; Dal “Regnum Langobardorum” al “Regnum Italiae”; Vindictam facere; Ultime menzioni delle ordalie e del duello giudiziario in Italia; “Antestare et defendere”; Note al X canone del concilio forogiuliese; Territori longobardi e territori romanici; Paolo Diacono e gli altri scrittori delle vicende d’Italia nell’età carolingia.
Aprendo la scheda bibliografica è possibile consultare i contenuti del volume in formato digitale.